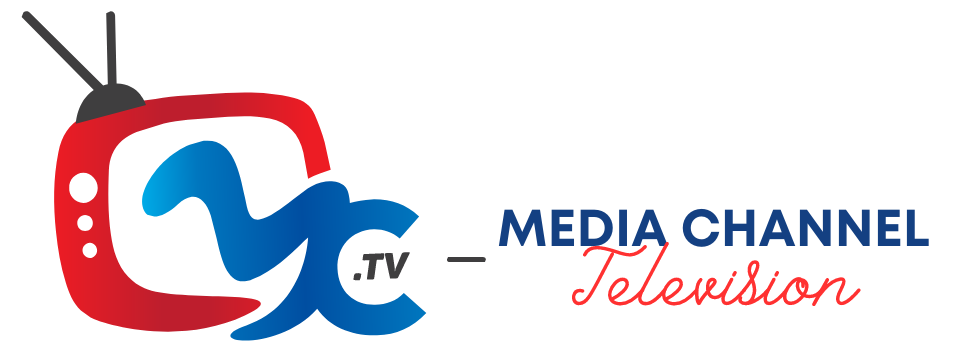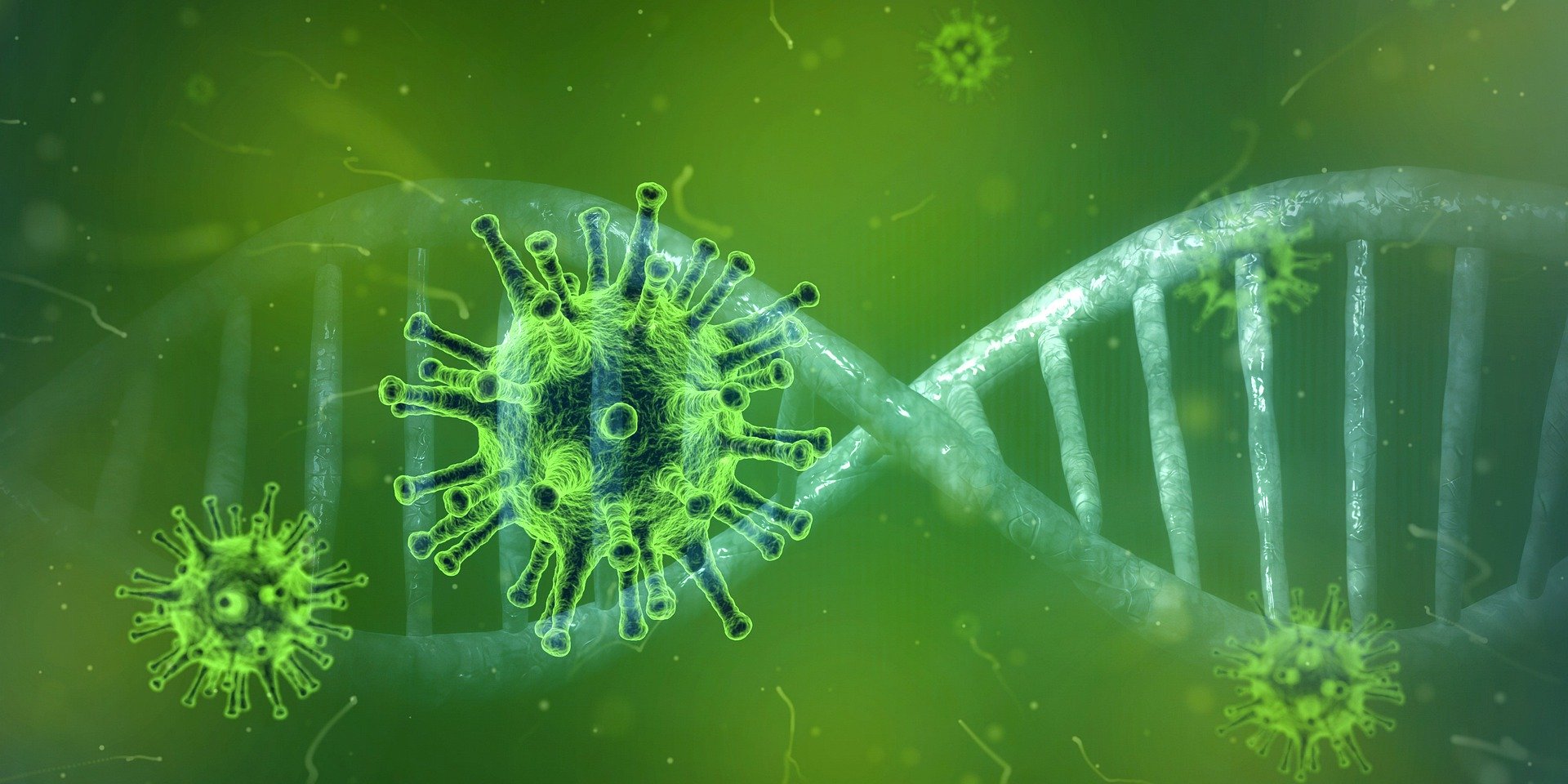
CORONAVIRUS: “TANTO NON CAPITERA’ MAI A ME”. LA TESTIMONIANZA DEL RICOVERO
Una lettera inviata al Corriere della Sera, che vogliamo riportare, scritta da una ragazza mentre aspetta l’esito del tampone per il Coronavirus. Tra le righe si comprende come alle volte quello che accade ci sembra distante un’immensità, ma che poi all’improvviso quando siamo noi realmente i protagonisti di quell’evento tragico ci troviamo del tutto spiazzati ed impauriti.
Una lettera che ci impone rispetto e prudenza per noi stessi, ma più che mai per gli altri che ci stanno intorno. Un’emergenza, quella alla quale siamo chiamati a combattere, da non prendere sotto gamba o con lo spirito dell’eroe immune; in gioco ci sono tante vite, soprattutto di coloro che sono più deboli.
“Non so voi, ma io ho la tendenza a vivere le situazioni incerte e potenzialmente pericolose come se non mi riguardassero; le assimilo a nubi gonfie di pioggia, a lontane manifestazioni meteorologiche destinate a dissolversi prima di raggiungere me. Che si tratti di un meccanismo di autodifesa, di semplice istinto umano o di pavidità, questo è stato il mio più spontaneo pensiero nel confrontarmi con la minacciosa nube-COVID-19: c’è da averne paura, certo. Ma non capiterà a me. Bene, oggi sono qui, semi seduta nel mio letto d’ospedale, a parlarvi di come io sia stata ricoverata, in isolamento causa sospetto COVID- 19, al Sacco di Milano; con la speranza che l’informazione aiuti a smitizzare ansie e paure, a comprendere meglio il procedimento dietro ogni diagnosi e a gettare un po’ di luce sul clima che si respira, oggi, negli ospedali, tra chi è impegnato in prima linea per fronteggiare una vera e propria emergenza nazionale.
Sono arrivata in ospedale alle 18.45 di lunedì 2 marzo. Dalla settimana prima soffrivo di quelli che, grazie a internet e ai telegiornali, abbiamo imparato a riconoscere come i sintomi del Coronavirus (che, nei casi più blandi, pare non si discostino molto dai sintomi della più comune influenza): febbre, tosse secca e insistente, cefalea a intermittenza, dolori diffusi, ma, soprattutto, un senso di costrizione al petto, come se non riuscissi mai a respirare al pieno della mia capacità polmonare, nonostante le cure prescrittemi dal mio medico di base e una dose quadrupla di formoterolo e budesonite, i miei quotidiani farmaci per l’asma.
Così, nel corso di una mia crisi respiratoria, lunedì pomeriggio la mia famiglia ha preso per me la decisione di chiamare il 118: nell’arco di dieci minuti, due operatrici sanitarie, mascherine ffp3 a coprire loro naso e bocca, erano già all’opera nel provarmi febbre, pressione e saturazione, nel farmi indossare a mia volta una mascherina e nell’approfondire la mia sintomatologia, oltreché eventuali contatti avuti con persone provenienti dalle cosiddette zone rosse – contatti, questi, impossibili da ricostruire con certezza per chiunque, come me, frequenti l’università a Milano e prenda abitualmente i mezzi pubblici. Quindi, le operatrici si sono messe in contatto con il Servizio Sanitario Nazionale, al quale hanno riportato tutta la mia anamnesi. Ho capito che mi avrebbero ricoverata, e dove mi avrebbero portata, sentendo la voce all’altro capo del filo prescrivere alle operatrici di procedere con la – loro – vestizione; terminata la quale (che mi ha garantito un minimo margine di tempo per racimolare un pigiama, spazzolino e dentifricio e qualche libro), senza tante spiegazioni né, tanto meno, rassicurazioni, sono stata caricata su un’ambulanza diretta al Sacco.
Una volta all’ospedale, ad accogliermi sono stati degli infermieri dotati di tute, copriscarpe, mascherine, cuffie e guanti, che mi hanno subito fatta accedere a una stanza di biocontenimento, il primo impatto con la quale non è stato rassicurante: sulla porta spiccava il simbolo del biohazard, un cartello informava che in quegli scarsi due metri per tre potevano sostare massimo tre persone per volta perché venisse rispettata una distanza di sicurezza di due metri, e un altro ancora che per comunicare con il personale medico bisognava premere un pulsante. Sedie di plastica, nessun tavolino, una porta a chiusura ermetica, un calorifero da campeggio per mantenere una temperatura accettabile malgrado il vento che filtrava da sotto la porta; seduta in un angolo, anche lei in attesa, c’era una donna, quando sono arrivata dormiva, poi mi ha detto di essere in attesa di una stanza, poi si è addormentata di nuovo.
Le ore trascorse in quella saletta sono state le più lente del mio ricovero – adesso, col senno di poi, penso che fosse anche perché non sapevo bene cosa sarebbe successo poi: nessuno me l’aveva anticipato, non c’era l’ombra di un medico, li pensavo impegnati altrove, con persone più gravi e sofferenti di me, eppure non riuscivo a smettere di chiedermi dove fossero tutti. Poco dopo mezzanotte, mentre provavo a dormire sdraiata alla bell’e meglio sulle sedie, la porta chiusa ermeticamente si è aperta, e per un istante ho creduto di stare vivendo un film: davanti a me c’erano tre medici, e il mio primo pensiero è andato agli astronauti pronti a un volo nell’interspazio; erano così ugualmente impersonali, coperti e mascherati a quel modo, che mi riusciva difficile distinguerli l’uno dall’altro, o capirli perfettamente quando parlavano.
Mi hanno fatta sdraiare su un lettino, e rivolto pressappoco, per metterle a verbale, le stesse domande che mi erano già state fatte; mi hanno misurato la temperatura, la pressione, il livello di ossigeno nel sangue; quindi un prelievo, e una radiografia al torace; e, infine, il tampone per verificare la positività o meno al COVID-19. La denominazione precisa è quella di tampone rino-faringeo; confesso di non essermi mai interrogata sulla natura di questo esame, prima di doverlo fare, e di aver erroneamente dedotto che mi avrebbero estratto un tampone di saliva dalla bocca. In realtà, il tampone rino-faringeo consiste, invece, nel prelievo di materiale esaminabile con l’aiuto di quello che sembra un cotton fioc di circa quindici centimetri di lunghezza; lo strumento viene inserito prima in una narice, poi nell’altra, e il risultato è una sensazione di dolore misto a fastidio, oltre che alla tentazione di starnutire. Tutti e tre i medici sono stati, nel corso dell’intera procedura, estremamente gentili e umani, nel tentativo di distrarmi, e persino di farmi sorridere; non l’ho dato per scontato, non a mezzanotte passata, non dopo chissà quanti altri tamponi ed esami fatti.
Questo genere di persone, chi continua a fare bene il proprio lavoro anche in situazioni di stress, ritmi serrati e allarmismo, sono coloro che più si avvicinano alla mia definizione di eroi moderni. A esami conclusi, e sempre con l’equipaggiamento – mascherina, guanti, copriscarpe – del caso, sono stata trasferita nell’area destinata alla degenza dei pazienti in attesa del risultato del tampone. In tempi normali, per esaminare un tampone bastano tre ore; all’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, intorno al 21 febbraio, la media dei tempi di attesa era di circa sei ore; oggi, complice la grande quantità di tamponi realizzati ogni giorno, i tempi di attesa [n.d.r.: almeno per quanto riguarda il Sacco, il cui team di infettivologi esamina i tamponi in loco, senza doverli spedire altrove] possono dilatarsi fino alle quarantott’ore. Non sapevo, inizialmente, quanto avrei dovuto aspettare; a dire il vero, l’idea dell’attesa, una volta entrata finalmente nella mia camera, non mi pesava neppure.
Le camere dei pazienti per i quali non si può escludere il contagio da COVID-19 sono singole, e strutturate come normali camere d’ospedale, non fosse per l’anticamera – in gergo: il filtro – che le separa dal corridoio del reparto, nella quale ai pazienti è vietato sostare: il filtro è dove gli infermieri depositano i pasti per i degenti; una volta usciti gli infermieri, i pazienti possono recarsi nel filtro, con mascherina e guanti, e portare in camera i pasti. Una volta in camera, possono stare senza maschera e guanti; prima che qualcuno entri nella stanza, vengono avvisati tramite interfono, e viene loro prescritto di indossare guanti e mascherine e di muoversi il meno possibile. I contatti con il personale medico sono ridotti all’osso: due volte al giorno, alle tre del pomeriggio e alle otto di sera, ai pazienti viene richiesto di provarsi la febbre, e di comunicare tramite interfono la propria temperatura corporea. Per quanto mi riguarda, ho ricevuto la visita di un medico solo il primo giorno, perché avevo la febbre alta; i restanti due, alle sei del mattino, quella di un’infermiera che passava a misurarmi la saturazione e a valutare le mie condizioni di salute.
A chiunque vedessi chiedevo con ansia degli esiti dei miei esami, che tardavano ad arrivare. Attraverso le pareti sottili trapelavano i rumori dell’ospedale intorno: le chiacchierate al telefono della signora nella camera accanto alla mia, risultata positiva al COVID-19 benché asintomatica; i colpi di tosse di altre due, forse tre persone. Dall’unica finestra, priva di maniglie e impossibile da aprire, come quelle dei grattacieli, non vedevo niente, perché il vetro era smerigliato e opaco. Avevo come l’impressione di essere sospesa fuori dal mondo.
Nelle circa trentasei ore di attesa del risultato del mio tampone, oltre a leggere e a tenermi informata, tramite social media, su quello che avveniva fuori, ho pensato principalmente due cose: uno: visto dall’interno, il COVID-19 sembra destare serie, serissime preoccupazioni; due: Dio benedica la sanità pubblica. Quanto alla prima affermazione, posso solo che motivarla dicendo che la mia percezione – la percezione non di un medico o di un virologo, ma di una comune cittadina che si sforza di tenersi costantemente informata sui fatti – è stata quella di una situazione di indubbia emergenza: le misure prese nei miei confronti sono state onnipresenti, calcolate al millimetro, restrittive a dir poco. Percepivo la cautela, il professionalissimo timore negli sguardi degli infermieri, la loro volontà di trattenersi il meno possibile nella mia camera; la stanchezza, anche.
La prima notte, l’infermiera che mi ha accompagnata in radiologia mi ha detto, mantenendo accuratamente la distanza di sicurezza di due metri: «In questi giorni sto ringraziando di non avere famiglia: i miei colleghi non riescono più a vedere mogli e figli. Non sanno che turni avranno, quando potranno dormire». Aveva gli occhi cerchiati e violacei, sopra la mascherina. Eppure era premurosa e attenta, mi ha chiesto quanti anni avessi, che scuola facessi, ha sorriso all’idea che fossi più grande di quanto pensasse; e premurosi lo sono stati tutti, sempre, a discapito di tutto. L’idea che in molti lottino da settimane e in silenzio, mettendo a repentaglio salute, ritmi di vita e legami affettivi dovrebbe aiutarci a ridimensionare il fenomeno, a capire che le persone coinvolte, al di 2 là dei veri e propri malati, di quelli che purtroppo sperimentano il COVID-19 sulla loro pelle, sono molte di più; che questa guerra riguarda noi, tutti noi, e non soltanto gli altri.
In secondo luogo, si diceva: Dio benedica la sanità pubblica. Non oso immaginare quanto il mio ricovero di tre giorni mi sarebbe venuto a costare se fossi stata, mettiamo, una cittadina dello Stato di New York: sei, settemila dollari? Ottomila? Il solo tampone rino-faringeo avrebbe sfiorato i tremila dollari; è facile tirare le somme, e concludere che una buona fetta della popolazione americana, con grande gioia del COVID-19, non potrà permettersi l’esame. Il nostro diritto alla diagnosi è alla portata di tutti, ed è giusto che sia così; ma non si dovrebbe dare per scontato, perché scontato non è.
Quanto a me, oggi, in data 4 marzo, a distanza di quasi trentasei ore, è arrivato l’esito del mio tampone: negativo. A comunicarmi il risultato sono stati due medici giovanissimi, forse specializzandi; hanno aperto la porta della mia stanza senza paura, sorridenti, quasi espansivi, hanno detto: «Portiamo buone notizie.» Li ho ringraziati con la stessa gratitudine che avrei voluto dimostrare a ogni medico, a ogni infermiere. In risposta loro mi hanno visitata, ancora una volta; mi hanno detto di prepararmi, che mi dimetteranno di qui a un’ora, un’ora e mezza. Ho ancora un po’ di tosse, ma niente più febbre. Io e i miei polmoni asmatici ce ne andremo di qui leggeri come non mai. Questa stanza verrà pulita, disinfettata, cambieranno le lenzuola, svuoteranno i cestini. Sarà presto pronta per qualcun altro.